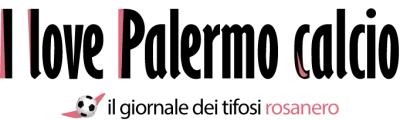Padovano «Mi sentivo Escobar. Ora voglio rivivere»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” riporta un’intervista a Michele Padovano.
La libertà, ora, è nell’aria fresca che Michele Padovano avverte intorno a sé, in quelle albe e in quei tramonti ripulite ormai prive di terrore e d’una vita che ricomincia a pulsare. Il verdetto della Corte d’Appello di Torino – assoluzione – spazza via quel senso d’impotenza, quel dolore sordo, e adagia in un angolo della memoria la notte in cui, 10 maggio 2006, scoprì che quelle tre “gazzelle” dei Carabinieri erano lì per lui, per arrestarlo, con un’ordinanza che l’accusava d’essere finanziatore d’un traffico di droga. Da Cosenza a Pisa, dal Napoli al Genoa, dalla Reggina alla Juventus, dal Crystal Palace al Metz e poi al Como divennero il nulla di fronte a una condanna – otto anni – e l’unica ragione per vivere è rimasta «l’ossessione di dimostrare la mia totale, assoluta innocenza». Ma il 31 gennaio del 2023 Padovano è rinato.
E ora Padovano respira. «Anche se mi sento come uno svalvolato. Mi sembra di essere reduce da una colossale ubriacatura o, peggio ancora, di essere uscito dalla fiamme dell’inferno».
6111 giorni fa, di sera, smise di esistere. «Uscivo da un ristorante dove ero andato a cena con alcuni amici, venni circondato da tre auto dei Carabinieri. La prima cosa che pensai fu: sono finito su Scherzi a Parte e cercavo di capire chi avesse potuto avere un’idea così macabra. Ma aspettavo i cartelli, ecco, ora arrivano».
Si trovò a Cuneo, in carcere, tre mesi. «E poi venni condannato: un iter infinito, quattro processi, il primo grado, l’Appello, la Cassazione che cancella la sentenza di condanna e poi l’assoluzione definitiva, quella che ha restituito me e la mia famiglia ad una serenità interiore assoluta. Non dovrò più svegliarmi pensando – temendo – che questo terribile equivoco possa continuare e io debba essere costretto alla vergogna per qualcosa che non ho commesso».
Ha attraversato momenti di disperazione. «Ma ho anche avuto modo di trovare, grazie alla mia famiglia e ai miei avvocati, la forza per reagire, per non essere travolto dal fango, per non crollare quando vedevo la gente sparire. Ho sentito l’affetto e l’amicizia di Presicci, mio compagno di squadra a Cosenza, e di Gianluca Vialli, che telefonava a mia moglie per chiedere di me e informarsi sulle nostre condizioni, e mi sono bastati. Chi mi ha evitato, chi non ha risposto alle mie telefonate, vuol dire che non doveva appartenere al mio vissuto: con quel fuggi fuggi generale, come se fossi un appestato, è come se ci fosse stata una selezione naturale».
Tra ingiusta detenzione ed errori giudiziari, in Italia c’è una media di circa mille casi all’anno… «Una enormità e tempi biblici per appurare la verità. Io ho avuto la fortuna di trovare i difensori giusti, Giacomo Francini e Michele Galasso, che sono diventati i miei santi protettori. E devo un grazie ai giudici che hanno riscontrato la mia assoluta onestà, la mia limpidezza. Ma diciassette anni stroncano l’esistenza di chiunque».
Nel 2020, lo Stato ha pagato 37 milioni per questi clamorosi abbagli. «Lascerò che siano i miei legali a guidarmi, saranno loro a indirizzarmi dentro i grovigli tecnici. Io ora mi godo questo momento, sensazioni che non mi appartenevano più, perché ormai stavo completamente immerso dentro le carte, le leggevo, rimanevo incredulo per le accuse. Ora l’incubo si è sgretolato, me ne sto con la mia famiglia, la mia àncora di salvezza».
Suo figlio Denis ha 31 anni, porta il nome del suo compagno di stanza Bergamini, scomparso 34 anni fa. «Glielo dico sempre, a mio figlio: è un nome importante. Eravamo insieme al Cosenza, mi stette vicino quando saltò il mio trasferimento alla Fiorentina, eravamo giovani, sognavamo. Sono stato al processo a testimoniare, mi auguro che i suoi – in attesa dal 1989 – possano conoscere la verità sulla sua morte».
Padovano a venti anni va a Cosenza, a trenta vince la Champions, a 40 si ritrova demolito. «L’immagine dell’arresto mi ha fatto compagnia ogni sera, quando cercavo di addormentarmi, e ogni mattina, quando mi svegliavo. Mi sentivo Pablo Escobar. In quell’istante, è stata fatta tabula rasa di Michele Padovano: non esistevano i successi, la felicità della finale di Roma contro l’Ajax, i gol al Napoli di Maradona, i suoi complimenti, poi la maglia della sua squadra. Non c’era più niente. Io sono stato disintegrato ma dovevo rialzarmi, non potevo arrendermi: lo dovevo ai miei, a me stesso, alla gente che credeva in me».
Ne ha trovato? «Paradossalmente, quando ho ricominciato ad uscire, dopo la detenzione, mi rincuorava l’affetto della gente, di chi era stato mio tifoso o anche no, di chi aveva percezione della mia natura, quindi della mia innocenza. Mentre il calcio mi ha chiuso le porte in faccia, a volte me le ha sbattute. C’era diffidenza, pregiudizio, io l’avvertivo e non me ne facevo una ragione quando riflettevo: ma come, mi hanno conosciuto, mi hanno frequentato, sanno chi sono! Però questo è il passato, lo lascio alle spalle. Ho avuto il coraggio di resistere all’infamia dell’arresto e di una condanna ingiusta, non cerco rivincite».
Ricominciare cosa significa? «Non so. Io a quarant’anni sapevo cosa avrei voluto fare da grande: avevo cominciato la carriera da manager, mi piaceva costruire qualcosa, metterci le mie conoscenze. Sono sempre stato affamato di calcio, l’altro ieri ho visto una gara di under 15 a Bergamo; dalla Champions ai Dilettanti, vedo di tutto. Magari faccio in tempo a ripartire. Ma la priorità sono mia moglie e mio figlio».
È giusto chiederle se è finalmente felice? «La cicatrice sta lì, perché stiamo parlando di diciassette anni bruciati, con conseguenze emotive che lasciano strascichi. Ma sono felice, posso dirlo. Voglio rivivere».