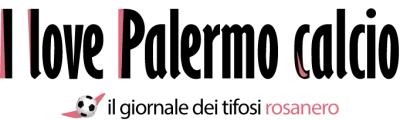Corriere dello Sport: “De Zerbi: «Sono tutti figli miei»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha riportato un’intervista a Roberto De Zerbi.
Il principale fornitore di talenti della Nazionale di Mancini è appena rientrato a Kiev dopo aver trascorso alcuni giorni nella sua Brescia. «Sul marciapiede dal ’94» si racconta così, Roberto De Zerbi, con un sorriso sfumato di amarezza, un’amarezza che stinge dal personaggio che abbiamo creato.
«Sono fuori di casa da quando avevo quindici anni e a 42 non sono ancora rientrato. Ne porto i segni. Ho dato e continuo a dare tutto me stesso al calcio e mi sono perso il resto. Il calcio procura vantaggi economici che pochi altri lavori possono offrire, e gratificazioni, notorietà, opportunità. Tutto si paga, però, e il prezzo è elevatissimo. La famiglia ne risente, e trascuri gli amici, hai preso strade diverse, di costante assenza, sei uscito dalla tua comunità. L’ho accettato prima ancora di volerlo. Per passione, la passione è il motore. Per questo mi sta sui coglioni chi il pallone lo sfrutta».
A chi ti riferisci, scusa?
«A quelli che lo vivono come un passatempo, un privilegio senza data di scadenza, un modo per campare bene, la macchina che produce soldi e garantisce visibilità. Non sopporto chi timbra il cartellino. Quando alleni, individui in un attimo chi è spinto dall’amore per il calcio e chi invece non ne ha, o non a sufficienza. Il successo inizia dalla passione per il proprio lavoro».
Che può indurre a mollare tutto per trasferirsi in Ucraina.
«Avevo bisogno di questa esperienza. Quella di Sassuolo si era esaurita naturalmente, sapevo che non avrei potuto dare di più. Volevo misurarmi con realtà nuove, con uno spogliatoio multilingue, con la Champions, le 8 partite da preparare e giocare in venticinque giorni. Avevo la necessità e il desiderio di affrontare difficoltà maggiori. Non è stato semplice lasciare Sassuolo, persone alle quali sono molto legato, io mi affeziono alla gente più che ai luoghi. Le difficoltà le sto effettivamente incontrando, ci sono momenti in cui faccio fatica e mi domando chi cazzo me l’abbia fatto fare. Però, quando mi fermo a riflettere, concludo che era quello che cercavo».
Allo Shakhtar sei condannato a vincere.
«Il livello cambia prospettive e metodi. Ci sono tanti modi di allenare, e sono legati agli obiettivi della società. Si allena per vincere i campionati, per andare in Europa, oppure per salvarsi. Oggi devo vincere e basta, misurandomi con le idee».
Le idee, i famosi princìpi di cui parli spesso.
«Una cosa è sviluppare le proprie, di idee, un’altra rubare quelle di altri. Il copia e incolla spesso non funziona. Quando porti cose tue, con convinzione e fiducia, la tua credibilità aumenta. Il calciatore è furbo, riconosce la finzione, il falso, ti sgama subito».
Il Sassuolo ha consegnato a Mancini Locatelli, Berardi, Raspadori, Scamacca e potrei aggiungere Acerbi e Pellegrini, che però non hai allenato.
«Mi ha colpito e mi ha entusiasmato il fatto che Raspadori sia riuscito a convincere i più diffidenti, i tanti che quando pensano a un centravanti lo immaginano sopra l’1 e 85 e gli 80 chili. Ricordo che anche le prime convocazioni nelle giovanili furono accompagnate da dubbi sulla sua struttura fisica. Giacomo è molto bravo e ha forza, la stessa gamba di Cassano. Con la tecnica, l’impegno e la professionalità ha fatto cambiare idea a molti. Oltretutto è un ragazzo stupendo».
Anche Berardi è stato in qualche modo sorprendente.
«La personalità, come si è imposto in Nazionale. Ragazzo d’oro, Domenico. Un introverso, silenzioso, chiuso, avrebbe potuto fare una carriera diversa, per le qualità che possiede, se soltanto l’avesse voluto. A Roma durante gli Europei ha fatto benissimo e nella finale di Wembley è entrato dopo poco meno di un’ora, è andato per primo sul dischetto e ha dimostrato di avere il carattere del protagonista, quello che chiedo sempre ai miei. Mi batto per far capire che non è importante andare in Nazionale, importante è farlo da protagonisti. Berardi mi ha sorpreso più di Loca».
In che senso?
«Locatelli ha una sensibilità non comune e una sana consapevolezza di sé. E sottolineo sana. Non si tratta di presunzione, possiede quel pizzico di narcisismo che serve, si sente il più forte di tutti e sa gestire bene questo aspetto. È di una maturità fuori dal comune. Il suo ingresso nella Juve è stato fin troppo naturale. Loca è malato di calcio, farlo star fuori il martedì alla ripresa degli allenamenti era impossibile. Voleva sempre lavorare. Quando dico che la differenza la fa la passione, lo porto a esempio. In Europa pochissimi giocano a un tocco come lui, prima di ricevere la palla sa già dove e a chi indirizzarla. E poi in tre anni non gli ho mai visto perdere un contrasto. Quando lo chiamai per convincerlo a venire a Sassuolo fissammo insieme l’Europeo come obiettivo. L’ha voluto e ottenuto».