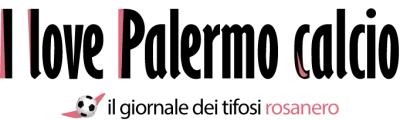Corriere dello Sport: “L’ex rosa Delio Rossi si racconta: «Quei presidenti convinti di capire di calcio…Cavani, Pastore, Vucinic i miei top. Ma era Liverani il più intelligente di tutti»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha realizzato una lunga e corposa intervista all’ex tecnico di Palermo e Lazio, Delio Rossi, ripercorrendo le varie tappe della sua carriera. Di seguito le parole dell’allenatore: “Delio Rossi non è fatto per le televisioni, per i social, per le banalità che, inevitabilmente, accompagnano la infinita settimana di un allenatore. È un passionale, sincero fino ad essere brutale. Ma capisce di calcio e lo ha dimostrato in molti casi. Il calcio è la sua vita ma la sua vita non è il calcio. È di più, ad esempio la famiglia che cura e difende. E una curiosità nel guardare le cose del mondo. Non solo del “suo” mondo, che forse sta cambiando in un modo che non gli piace.
Inizierei dalla passione da bambino per il calcio. Com’è cominciata? «In me è cominciata più che altro la passione per lo sport in generale. Non prevalentemente per il calcio, visto che vivevo in un posto di mare e le mie prime passioni sono stati il nuoto, la pesca, la canoa, visto che quello era il mio mondo. Poi c’è stato il tennis, le campestri a scuola. Ma avevo mio fratello che giocava al calcio quindi, per spirito di emulazione, ho iniziato a giocare anche io a football».
Dove ha cominciato a giocare? «Al paese, lì a Torre Pedrera, vicino a Rimini. Giocavo nella squadretta dei miei coetanei. C’era un settore giovanile, ma proprio alla buona».
Quanti anni aveva? «Dodici, tredici. Ma in verità ho sempre giocato anche a calcio perché era lo svago più semplice. Si giocava a scuola oppure sul sagrato della chiesa. Allora non esisteva Internet, non esisteva la televisione, stare insieme agli amici e calciare un pallone era il modo giusto di sentirsi bambini, insieme».
In quel momento chi era il suo idolo di calciatore? «No, non avevo idoli. Mi piaceva muovermi, correre, tirare in porta, ma non avevo idoli. Anzi, se devo essere sincero, non vedevo neanche le partite in tv».
Quindi le piaceva giocare ma non era un tifoso di calcio? «No, la prima partita che ho visto era dei Mondiali del ’70. La prima partita che ricordo: Brasile-Italia».
La finale? «La finale e la semifinale, quella con la Germania. La ricordo anche perché era estate, stavamo al mare sul nostro litorale che, come è noto, è sempre stato pieno di tedeschi. Mi ricordo che loro si riunivano nei bar perché erano sicuri di vincere e quella sera, a causa degli sfottò dopo il gol di Rivera, scoppiò una rissa megagalattica. E mi rivedo, bambino di dieci anni, mentre giro per il lungomare con la bandiera italiana alla fine del primo tempo della finale, quando stavamo pareggiando con il Brasile».
Come comincia a giocare seriamente a calcio? «Mio fratello giocava nelle giovanili del Rimini calcio che era in serie B o serie C, adesso non ricordo. Lui è 5 anni più grande di me e vedevo che lo faceva con passione. Io invece giocavo nella squadretta del paese. Alla fine dell’anno il Rimini calcio prese quattro miei compagni per portarli nel settore giovanile ma io non fui scelto. Mio fratello chiese ai dirigenti: “Ne avete presi quattro, ma perché non pigliate pure mio fratello?”. Gli risposero seccamente che non gli interessavo. Ma lui insistette e mi portarono a giocare nelle giovanili. A fine anno gli altri quattro tornarono indietro e rimasi solo io. Una bella soddisfazione».
In che ruolo giocava? «Difensore, terzino».
Però poi diventò centrocampista, no? «No, quella fu un’invenzione. Io sono sempre stato terzino. Fu un’invenzione di Zeman quando giocavo nel Foggia. Lui giocava con due terzini che erano ali e voleva un centrocampista che coprisse questi terzini. Quindi io facevo il terzino a metà campo, praticamente. Non ero davvero un centrocampista puro».
Quindi la sua esperienza da calciatore più importante è stata col Foggia? «Ho fatto tutta la trafila, poi ebbi dei problemi con il responsabile del settore giovanile che mi disse, dopo che avevo compiuto diciotto anni: “Tu secondo noi al massimo puoi giocare in seconda categoria, ti abbiamo trovato una squadra”. Io risposi che in seconda categoria ci andavo da solo, non c’era bisogno che una società me la trovassero loro. “Mi state dicendo che non sono fatto per giocare al calcio”. Presi atto di questo giudizio e dopo che avevo fatto la Primavera, dissi loro: “Sto andando all’università, comincerò a studiare e giocherò solo per divertirmi”. Così mi liquidarono, a Rimini. Poi ci furono dei tornei estivi e chiamavano sempre mio fratello. Lui, per la seconda volta, disse: “Se volete che venga io dovete fare venire mio fratello”. Mi ricordo che entravo solo nel secondo tempo, ma feci bene e mi contattò una squadra di quarta serie che era il Forlimpopoli. Poi andai al Cattolica e poi al Foggia. Ma questa è un’altra storia».
E con Zeman che rapporto ebbe? «Zeman è stato il mio allenatore a Foggia, lui arrivò in serie C. Ma ci retrocessero per un illecito in C2 e lui se ne andò, quando ci tolsero i punti. Ricordo che noi eravamo in ritiro e ci diedero la comunicazione che ci avevano retrocesso in una categoria inferiore. Fu lì che iniziai a fare l’allenatore perché ci autogestimmo e io fui uno dei due che gestirono questa situazione intermedia. Poi ci inflissero 6 punti di penalizzazione nella categoria superiore e allora Zeman tornò. Lui fu il mio allenatore per otto mesi. Poi lo esonerarono, perché ebbe dei problemi con il presidente. Ci siamo ritrovati quando ho fatto la Berretti e la Primavera del Foggia nel tempo in cui lui era allenatore della prima squadra. Stiamo parlando di serie A».
Che cosa le piaceva del mestiere di allenatore? «Guardi, nel frattempo mi ero iscritto all’università, laureandomi in educazione motoria. Mi è sempre piaciuto lo sport in generale. Avevo passione per la preparazione atletica. Ero molto curioso, mi appuntavo note su tutti gli allenamenti. Ho ancora le considerazioni sugli allenamenti con Zeman. Avevo questa passione, che però non esternavo. Se ne accorse il direttore sportivo di allora del Foggia che, di punto in bianco, mi disse: “Ma perché non smetti e inizi a fare l’allenatore?”. Io rimasi interdetto all’idea di appendere le scarpe al chiodo. Avevo solo 27 anni. Ero già padre di due figli e mi sono chiesto cosa gli avrei fatto mangiare. Poi ebbi un infortunio al ginocchio e iniziai ad allenare i dilettanti. Vinsi il campionato, poi andai nel settore giovanile del Foggia. Feci tutta la trafila e dopo otto mesi mi passarono in Primavera e lì iniziò la mia vera carriera».
Qual è la cosa che ricorda con più piacere dell’avventura da allenatore di calcio? «Mah, ce ne sono due. Penso il primo anno dei dilettanti. Ero in una specie di limbo, non sapevo se continuare a stare nel calcio. Ma avevo dei doveri nei confronti della mia famiglia e dovevo dargli da mangiare. Nel frattempo ero diventato professore di educazione fisica, però mi arrivavano le supplenze e io rispondevo sempre no. Mia moglie si arrabbiava perché diceva: “Scusa, vuoi smettere di giocare a pallone e però non vuoi andare a scuola, che facciamo?”». La verità è che io volevo fare l’allenatore ma nessuno mi dava la possibilità di cominciare. Un giorno arrivò una chiamata di un mio amico che faceva il direttore sportivo lì vicino e io dissi a mia moglie che mi offrivano un posto di lavoro. Non era vero, però mi dava la possibilità di fare l’allenatore. Iniziavo ad allenare dalle tre del pomeriggio fino alle undici di sera, perché chi andava a scuola veniva alle tre del pomeriggio, poi alle cinque arrivavano quelli che lavoravano in fabbrica e poi alle nove un ragazzo che lavorava con il padre che faceva il muratore. Mi ricordo che ci allenavamo al buio io e lui e che cinque volte alla settimana restavo ininterrottamente dalle tre alle nove di sera. Una cosa che ricordo è che dalle sette alle nove c’era un buco di tempo, non arrivava nessuno e dovevo aspettare. Faceva freddo d’inverno, non c’erano stufe e i vetri erano rotti. In quegli spogliatoi, non so perché, c’erano i caschi, quelli dei parrucchieri delle donne. Allora, per avere caldo, mi facevo tipo una messa in piega».
E questo è il primo ricordo piacevole. Il secondo? «Il primo campionato che ho fatto nei professionisti. Dovevo rimanere due mesi alla Salernitana perché nel frattempo la società era in vendita e dunque doveva esserci uno per gestire questa transizione. Era un gruppo un po’ raccogliticcio di ragazzi, invece vincemmo il campionato. Forse le squadre alle quali sono rimasto più legato sono la Salernitana della serie C e i ragazzi del Torremaggiore, che sento ancora».
Facciamo un salto temporale. Come è stata la sua esperienza alla Lazio? «Sono entrato in punta di piedi, venivo da buone prove: avevo vinto il campionato di C, di B con la Salernitana, ancora quello di B con il Lecce e avevo fatto bene a Pescara. Poi mi ero salvato in serie A con il Lecce e a Bergamo stavamo per salvarci. Lì mi mise gli occhi addosso il presidente della Lazio. Non ho mai saputo come mai sono arrivato soprattutto con giocatori importanti come Liverani, Oddo, Peruzzi. Ma era un periodo di transizione perché il presidente della Lazio aveva salvato la società da un fallimento e bisognava iniziare un progetto nuovo».
Però ha ottenuto dei risultati importanti alla Lazio. «Sì, devo dire che però l’ho allenata e mi sono comportato come avevo fatto a Torremaggiore, quella delle messe in piega, e come a Foggia a Lecce, o dovunque sia stato. Ho portato avanti le mie idee, non pensando che ero in una società importante come la Lazio. Quando alleno, vivo 24 ore al giorno in campo, al centro sportivo, o studiando calcio. E a casa sto senza leggere i giornali, senza sentire le radio, le televisioni. Penso solo a lavorare, cercando di migliorare i giocatori che ho a disposizione e devo dire che, finora, è andata, tutto sommato, bene».
Poi perché è finito il rapporto con la Lazio? «Sono rimasto cinque anni, un periodo lungo per la media italiana. È stata un’esperienza bella e importante, alla quale sono legato. È finita per diversità di opinioni col presidente. Faccio una premessa: nel momento stesso in cui io lavoro per una società, so che io non sono il padrone di questa squadra, sono un dipendente. Devo portare avanti le idee della società; nel momento in cui firmo un contratto e l’accetto, so che devo allenare una squadra e cercare di fare meglio possibile. Ci fu uno screzio con il presidente perché noi superammo i gironi di qualificazione di Champions, pareggiando in casa e poi vincendo in Romania. Quindi passammo ai gironi di Champions, quelli importanti, e lì mi furono promessi dei rinforzi, necessari per affrontare degnamente quel torneo. Mi garantirono l’arrivo di quattro giocatori, non se ne vide neanche uno.. Prendemmo solo Vignaroli, svincolato dal Bari. E allora ho detto quello che pensavo al presidente, gli ho detto che quello che era successo non era giusto né corretto nei confronti dei tifosi, degli altri giocatori, del mio lavoro, della Lazio stessa. Fare una Champions League non all’altezza significava buttare via tutto il lavoro precedente. Ho esperienza e sapevo che nel momento in cui avevo espresso questo pensiero a quattr’occhi al presidente, la mia storia alla Lazio era finita. Poi la stagione successiva vincemmo la Coppa Italia. Mentre alzavo, con i miei giocatori, quella coppa tanto attesa sapevo che non sarei più stato l’allenatore della Lazio».
Per parlare di altri presidenti particolari, come è stato il suo rapporto col Palermo e con Zamparini? «Non tutti i presidenti sono uguali. Zamparini è diverso da Lotito, è diverso da Aliberti, è diverso da tutti quelli che ho avuto. Hanno una caratteristica: dopo un po’ pensano tutti di capirci di calcio. Molte volte è vero, ma se io e lei vediamo una partita, la vediamo alla stessa maniera e magari concordiamo nell’individuare delle défaillances, delle difficoltà, dei difetti. La differenza è che, nel momento in cui lei ha visto queste mancanze, è finito il suo lavoro. Lì invece inizia il mio lavoro. Questa è la diversità. Molti pensano che sia facile, che basti fare questo o quest’altro. No, non è così, anche perché il calcio è come la scuola. Bisogna insegnare: uno pensa che partire da A e poi andare a C sia sempre un fatto graduale, lineare. Invece non è così perché parti da A poi vai a B ma poi ti sei dimenticato A e poi può darsi che C lo sai fare ma poi devi ritornare indietro. Il bello dell’insegnamento, dell’apprendimento è questo, è l’attenzione costante, perché se dai per scontato qualcosa, sbagli. Io alleno sempre come fosse la prima volta, anche se sono da quattro anni con una squadra, perché se non rinverdisci certi concetti con i giocatori, finisci con perderli. Invece i presidenti pensano in maniera erronea che un allenatore vale un altro e pensano che allenare sia facile. Non è così semplice. Per lo meno non è così schematico».
Qual è la prima cosa che dice ad una squadra quando comincia il primo giorno di lavoro? «Che io mi metto a loro disposizione, basta che loro si mettano non a mia disposizione, ma a disposizione della squadra. Non dimentico mai che il calcio è uno sport di gruppo, che a vincere o a perdere è una comunità, non un singolo. Adesso i giocatori sono diventati quasi tutti imprese individuali. E molte volte l’interesse individuale va a cozzare con l’interesse collettivo. Faccio un esempio banale: io ho un centravanti che mi fa dieci gol e arrivo settimo, se l’anno dopo lo stesso centravanti mi fa tre gol e la squadra arriva terza, io sono felice ma quel giocatore non lo è. Come squadra tu hai raggiunto l’obiettivo, sei andato magari a fare le coppe europee, però il suo potere all’interno della squadra, sia economico che di prestigio, era superiore l’anno prima e quindi è insofferente. Questi problemi li devi affrontare tu, anche perché il presidente non ci si vuole immergere…».
Quindi c’è una solitudine dell’allenatore? «Sempre, sempre l’allenatore è solo. Anche quando ritira un premio l’allenatore è solo, perché deve sapere che poi verranno anche altri momenti, i più duri, in cui non ci sarà nessuno vicino. Io sento molto il calcio, anche come prova, come sfida. Un trofeo vinto non ripaga una sconfitta. Se perdo mi assumo anche delle colpe magari non tutte mie, perché può darsi che io dovessi essere più bravo. Invece la vittoria la do per scontata perché frutto del lavoro che stai facendo».
Vogliamo spiegare una volta per tutte quella vicenda di Ljajic come andò? «Per me è una storia che era già chiusa lì. Credo sia tutto chiaro, ma non voglio tornarci. Non mi va che quell’episodio venga ricordato più di una coppa Italia vinta».
Una volta mi disse che il giocatore più forte che ha allenato in vita sua è stato Vucinic, me lo conferma, qualche anno dopo? «Forse perché non avevo allenato ancora Pastore, non avevo allenato Cavani…».
Adesso chi direbbe? «Vucinic aveva questa qualità, che è dei grandi giocatori, di unire tecnica e velocità. Il giocatore più talentoso che ho avuto è stato Pastore, estro puro, cioè il genio che tira fuori il coniglio dal cilindro. Come attaccante più forte sicuramente direi Cavani, incredibile forza fisica. Però questa capacità che aveva Vucinic di coniugare tecnica e velocità non l’ho vista in tanti».
Il giocatore più intelligente che ha allenato? Quello che in campo per lei faceva un po’ da regista chi è stato? «Liverani. Il giocatore più intelligente, giocava sempre sulla traiettoria, sembrava non andare mai al contrasto. Poi i dati ti dicevano che aveva recuperato più palloni di tutti, però in campo non te ne accorgevi. Si vedeva che un domani avrebbe avuto la capacità tecnica di poter fare l’allenatore, perché lui era l’allenatore in campo. E non ce ne sono stati tanti: di solito il leader tecnico non corrisponde al leader caratteriale o leader morale. Cioè tu magari a uno gli daresti da sposare tua figlia, ci andresti a cena, perché lo vedi che è uno moralmente a posto ma quasi sempre è uno che non ha le capacità tecniche. E difficilmente la capacità tecnica si abbina al discorso morale. Se trovi queste persone, io ne posso contare una o due, allora sì, hai il leader. Ma il leader tecnico molte volte pensa solo ed esclusivamente a se stesso e quindi non è un leader morale, e allora non è riconosciuto dagli altri».
Cosa le manca, in questo tempo senza una squadra da guidare? «Il campo. Ma quando parlo del campo non mi manca la panchina, mi manca la quotidianità, cioè l’odore dell’erba, andare lì e fare le selezioni dei giocatori magari al buio, insegnare ad un ragazzo la posizione dei piedi, come si mette il piede d’appoggio, come si crossa oppure tenerlo lì a lavorare sul sinistro che magari è solo destro. Mi manca questo, non mi manca la panchina, mi manca la quotidianità del lavoro, di sentire il profumo dell’erba del campo di gioco. Non mi manca la domenica. La domenica, secondo me, è il giorno nel quale l’allenatore incide di meno. Tutti pensano che sia il momento decisivo, se fa un cambio, se non lo fa. Invece se hai lavorato bene durante la settimana, la domenica è solo la fotografia di quello che hai fatto»”.